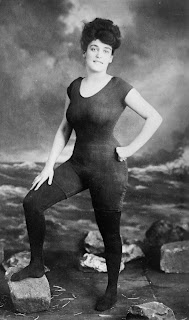Gli anni della
leggerezza, il primo volume della Saga
dei Cazalet dell’autrice inglese Elizabeth Jane Howard, fortunatamente
riscoperta dalla Fazi negli ultimi anni, era nella mia wishlist per i regali dello scorso Natale. Ci pensò mia madre a
regalarmelo, ma nonostante fossi curiosissima di scoprirne i contenuti, ci è
voluto un bel po’ di tempo prima che mi dedicassi a leggerlo. Un po’, immagino,
perché era uno dei romanzi più in voga del momento, in parte solo perché
aspettavo l’ispirazione giusta. Quando questa è arrivata – se non ricordo male
a Settembre – Gli anni della leggerezza
l’ho divorato in pochissimo tempo, a dispetto delle sue seicento e passa
pagine. Tuttavia non ne ho lasciato traccia qui sul blog, e nemmeno sul mio
profilo di Anobii. Il motivo è semplice: mi era piaciuto tantissimo, sì, ma
faticavo ad immaginare di spiegarne il perché in un commento che valesse la
pena diffondere. Sentivo che se mi fossi cimentata nel tentativo di raccontare
le mie impressioni il risultato sarebbe stato banale, superfluo, vuoto rispetto
a ciò che in realtà il libro mi aveva trasmesso. Perciò ho preferito lasciar
stare, ho preferito rifletterci su per conto mio, cercando di approfondire tramite
qualche ricerca ed il ricordo ancora vicino dove si nascondesse la grandezza
della scrittura della Howard.
Penso che ormai tutti abbiate sentito parlare dei Cazalet,
tanto che non mi sento in dovere di raccontarvi qualcosa della trama; ma non
posso commettere l’errore di dar per scontato che davvero ognuno di voi sappia
di cosa sta parlando quando si nomina la famiglia nata dalla penna della
Howard, perciò almeno una veloce spiegazione ve la devo. La saga dei Cazalet, che si articola in più volumi, racconta le
vicissitudini di una famiglia inglese alto-borghese, proprietaria di una ditta
di legname, a cavallo tra le due Grandi Guerre. Nel primo volume la paura che
scoppi il secondo conflitto mondiale si sta spandendo rapidamente, ma si
conclude con un momentaneo scampato pericolo; nel secondo volume invece siamo
nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.
Tra i Cazalet troviamo anzitutto i capostipiti,
affettuosamente soprannominati il Generale e la Duchessa, intramontabili
baluardi dell’epoca vittoriana. Poi ci sono i loro tre figli maschi – Hugh,
Edward e Rupert – tanto diversi tra di loro che si stenterebbe a crederne la
parentela. Hugh, il maggiore, è un eroe della Prima Guerra, che gli ha lasciato
in ricordo un moncherino al posto della mano sinistra e tanto ricorrenti quanto
dolorose emicranie. Hugh è un uomo attento nel lavoro, riservato nella sua
vita, premuroso con la moglie e affettuoso con i figli: un uomo buono. Edward è
invece l’esatto opposto, è istintivo, famelico, vorace; il più affascinante dei
tre, anche lui reduce dal primo conflitto dal quale però è tornato senza un
graffio. Marito e padre superficiale, non si accontenta di un’unica donna né di
un’unica amante: il classico uomo che non sa tenerlo nei pantaloni. Rupert, tra
i tre, è probabilmente il mio preferito. Troppo giovane per arruolarsi ai tempi
della Prima Guerra, appassionato di arte col sogno di fare della pittura il suo
mestiere, anche se per mantenersi ha ripiegato al momento sull’insegnamento.
Combattuto quindi tra la necessità di seguire la propria vocazione e quella di
mantenere una famiglia, un uomo tutt’altro che rinunciatario ma capace di fare
dei sacrifici. Spezzato dalla morte della sua prima adorata moglie, piegato
dalla fatica di bastare a due figli tanto più bisognosi d’amore a causa della
perdita materna e per di più intrappolato dalla bellezza della sua seconda
moglie, innamoratissima di lui ma troppo giovane per comprenderlo. Infine c’è
Rachel, l’unica figlia femmina rimasta nubile, spalla e bastone per la
vecchiaia dei genitori. Rachel è fin troppo generosa, quel tipo di persona che
non fa altro che aiutare anche quando avrebbe bisogno d’aiuto lei per prima.
Uno spirito profondamente materno, che un po’ si dispiace a non esser sfruttato
su un figlio suo. Rachel, a sua volta apparentemente tanto semplice, serba un
segreto: un segreto importante, intimo e vissuto gelosamente.

Hugh è sposato con Sybil, che è un po’ la sua versione al
femminile. Di Sybil, ad esser sincera, non mi ha colpita nulla in particolare,
non quanto la natura del loro rapporto: Hugh e Sybil sono forse gli unici tra i
coniugi Cazalet ad amarsi di un amore vero, ma nonostante questo sono incapaci
di costruire un vero dialogo. Loro due pensano di conoscere l’altro alla
perfezione, credono di sapere sempre cosa preferirebbe in ogni piccola
situazione e per quest’eccesso di reciproca gentilezza danno luogo ad
un’infinita serie di equivoci che creano – senza che nessuno lo ammetta –
disagio ad entrambi (piccolo rapido esempio: Hugh non vuole il caffè ma crede che
Sybil lo gradisca, così le propone di prenderne uno; neanche Sybil, in realtà,
vuole un caffè ma dal momento che Hugh l’ha proposto pensa che a lui faccia
piacere, quindi accetta). A qualsiasi spettatore esterno può sembrare un
rapporto insensato, logorante, esasperante ma per loro funziona benissimo
nonostante talvolta il “non detto” riguardi faccende un tantino più importanti
delle piccole inezie quotidiane.
Edward e Villy sono senz’altro la coppia più finta tra i
Cazalet e non soltanto per i continui tradimenti di lui. Villy forse non
tradisce, e forse in qualche modo suo marito lo ama anche, è solo che non era
una donna tagliata per il matrimonio. Nel primo volume, anche se non
particolarmente simpatica, Villy è uno dei personaggi che ho trovato più interessanti.
Per il matrimonio aveva lasciato la sua carriera di ballerina di danza classica
con una compagnia russa, pensando che fosse una scelta saggia, giusta, normale
che l’avrebbe condotta verso una vita altrettanto appagante; invece, il ruolo
di moglie e madre si era rivelato per lei insufficiente, più stretto di un
soffocante corpetto. Nonostante tanta personale insoddisfazione, nessuno
sospetterebbe l’inquietudine di Villy, la quale appare impeccabile in ogni
momento ed in ogni contesto, comportandosi sempre come tutti gli altri si
aspettano; la frustrazione, poi, la sfoga buttandosi con tutta se stessa di
volta in volta in una nuova attività – imparare una lingua straniera, a suonare
uno strumento, una tecnica di cucito – fino al raggiungere la perfezione, per
poi passare ad altro.
Il rapporto tra Rupert e Zoe, invece, è ancora giovane,
giovane come lei che nella vita non si è preoccupata d’altro che della sua
bellezza, incitata anche da una madre povera e sola che nello splendore
estetico di quell’unica figlia adorata ha visto ogni singola possibilità di
riscatto per entrambe. Rupert non è esattamente il riccone che la madre si
auspicava per Zoe – e per se stessa – ma Zoe, nel momento in cui lo incontrò
per la prima volta, non pensò a niente di tutto questo. Nonostante a primo
impatto Zoe sembri infantile e capricciosa, ho colto in lei qualcosa di
selvatico che subito l’ha fatta scattare in vetta tra i favoriti. Difficile per
lei accontentarsi del tempo con Rupert, che quand’è libero deve dedicarsi anche
a quei suoi due bambini orfani di madre; difficile per lei, nient’altro che
tanto innamorata, non passare per bambina egoista; difficile per lei farsi
accettare da un bambino nervoso e da una ragazzina che in pratica la odia. Zoe
è una gatta, bella e indomita, dolce e ribelle, capace di arrampicarsi e di
cadere in piedi.
Se dovessi poi soffermarmi su tutti i figli ci starei
un’eternità né potrei dire molto su ognuno: non tutti i giovani Cazalet infatti
compaiono molto sulla scena. I maschi, per esempio, per la maggior parte del
tempo sono via per la scuola o altre attività. Quelle che hanno più spazio
nella narrazione sono le tre cugine Polly, Clary e Louise, che fin dall’inizio
– tra tutti – hanno attirato particolarmente la mia attenzione. Polly che non
ha idea di cosa fare nella sua vita, Polly così buona, gentile e premurosa con
tutti, che coi suoi soldi compra oggetti bizzarri da mettere da parte per
realizzare l’unico desiderio che è sicura di avere: avere una casa tutta sua
dove mettere tutte quelle cose e dove vivere serenamente con qualche gatto a
tenerle compagnia. E Clary, il contrario di Polly, brusca e scontrosa ma
soltanto bisognosa di affetto, in continua lotta per sentirsi accettata, col
talento per la scrittura che sboccia fino a diventare un’ambizione insopprimibile.
E Louise, di poco più grande di loro, abbastanza da non aver più nulla in comune
nel giro di un’estate. Louise che conosce tutto Shakespeare a memoria, sicura
soltanto di voler fare l’attrice; Louise che impara a sconfiggere la nostalgia
di casa, Louise che non sente l’amore di sua madre, Louise che l’amore di suo
padre tende ad essere di un tipo sbagliato, Louise che in valigia mette
sofferenze e paure.
Ma la gamma dei personaggi non si limita neanche a chi porta
il cognome Cazalet: la narrazione sbalza tra i componenti della famiglia e le
persone al suo servizio, in quella fortunatissima forma ripresa nella serie tv Downton Abbey (che ora posso anche
sospettare essere praticamente copiata – con qualche significativa modifica –
dai libri della Howard); come dimenticare poi Miss Milliment, l’istitutrice
delle ragazze, un personaggio capace, dignitoso e sofferente per cui ho avuto
un debole dall’inizio; e poi Sid, l’amica di Rachel, musicista di talento,
ebrea per metà, quasi parte della famiglia, legata ad una sorella che è una
zavorra, impossibilitata dalle circostanze a viversi la vita per come la
vorrebbe. Tanti sono i personaggi che passano per queste pagine, ospitati nella
grande casa del Generale e della Duchessa nella campagna del Sussex.

Se mi fossi lanciata a scrivere un commento dopo aver letto
il primo volume, avrei fatto un ritratto dei personaggi principali così come ho
fatto ora e poi avrei aggiunto che il tratto più forte che mi rimaneva di
questa grande famiglia era l’aura di serena falsità che aleggiava su tutti
quanti. Trovavo straordinario come tutti sembrassero assolutamente ordinari,
persone semplici, persone qualunque e di come invece sondandone pian piano
l’intimità di ognuno emergesse una complessa unicità, di come tutti questi
inglesi pacati, abitudinari, col tè in mano alle cinque in punto serbassero nel
quotidiano tumulti così forti, conflitti interni ed esterni, ambizioni e
rinunce: i Cazalet non parlano. Li immagino tutti seduti intorno al grande
tavolo, ben vestiti, ben pettinati, col sorriso cordiale sulle labbra. Parlano
di Hitler, di politica interna ed internazionale, parlano di musica, di arte,
dei ragazzi, di cosa fare l’indomani. Nessuno, però, si sognerebbe di esprimere
la preoccupazione per la possibilità di essere arruolato, o di sfogarsi per una
gravidanza indesiderata, o della paura di essere malati, o della difficoltà di
separarsi da un figlio che come gli altri deve andare a scuola lontano da casa.
E’ un’attitudine che i più giovani hanno già notato, ogni qualvolta pongono una
domanda e gli adulti si rifiutano di rispondere (che cos’è uno stupro? Nessuno me lo spiega! Mi hanno detto che devo
averne paura, ma come faccio ad averne paura o ad evitarlo se non so neanche
cosa sia?).
Ho capito quanto la saga
dei Cazalet mi avesse coinvolta quando, a metà del mese in corso, di punto
in bianco ho sentito un bisogno quasi fisico
di tornare tra loro, al punto da fare una cosa che ormai faccio raramente (più
per possibilità che altro) ovvero uscire, dirigermi a passo svelto in libreria,
e sborsare i diciotto euro necessari a portarmi a casa il secondo episodio, Il tempo dell’attesa. L’attesa è quella
della fine di una guerra che sembra durare da sempre e non finire mai, una
guerra che mette in pausa tutto il resto, che rende difficile condurre
un’esistenza normale. Non si sta
combattendo in prima persona, eppure non si può neanche portare avanti i propri
sogni e progetti. Gli adulti riescono anche a cavarsela, con tutte le loro cose
da fare, ma crescere in quest’atmosfera di stand-by è ben più difficile: non a
caso, ne Il tempo dell’attesa interi
capitoli sono affidati alle voci di Polly, Louise e Clary, ormai in piena
adolescenza.

Se possibile,
Il tempo
dell’attesa mi è piaciuto ancora di più de
Gli anni della leggerezza. Sono davvero tanti gli avvenimenti che
scandiscono la vita degli ancor più numerosi personaggi, tante le storie dentro
le storie, tanti i cambiamenti, le evoluzioni tanto nei rapporti quanto
nell’interiorità di ognuno. Ma non ha senso svelarvele, il bello sta tutto
nello scoprirle pagina dopo pagina. Ma più di tutto,
Il tempo dell’attesa mi ha svelato dov’è che sta la grandezza della
scrittura di Jane Howard – come preferiva essere chiamata – che giustamente la
sua amica e scrittrice Hilary Mantel ha paragonato a Jane Austen, per quella
predilezione degli ambienti domestici e provinciali come materiale narrativo.
Ecco, ad essere incredibile è la capacità della Howard di modificare il tono ed
il peso delle sue parole a seconda del personaggio trattato: lei sa rendere più
che credibili tanto gli uomini quanto le donne, tanto le difficoltà di una
tredicenne quanto i moti interiori di una diciottenne; sa rendere reali tanto i
problemi di un anziano che perde autonomia a causa degli acciacchi della vecchiaia,
quanto quelli di un bambino. Sono stati proprio i paragrafi in cui protagonisti
sono i bambini a farmi saltare all’occhio questo particolare: Lydia e Neville
sono spassosi, leggendo i loro battibecchi e le loro serie disquisizioni è
difficilissimo non farsi una risata e al contempo sono realistici. I loro dubbi
non sembrano quelli di un adulto che ha tentato di farsi bambino, ma sembrano
proprio quelli che potrebbe venire a porci – spiazzandoci – il settenne di
turno. Questa grande capacità denota che, prima che come scrittrice, Jane
Howard aveva un grande talento come osservatrice e che doveva essere molto
brava a mettersi nei panni degli altri.
In quest’opera gigante che è la saga dei Cazalet la scrittrice ha messo molto di sé, del suo
vissuto, della sua famiglia. In particolare, nella figura di Louise: anche la
Howard, infatti, aveva intrapreso la strada della recitazione e purtroppo Villy
ed Edward, i genitori di Louise, sono il ritratto dei genitori della Howard. La
madre di Jane Howard aveva abbandonato la carriera da ballerina esattamente
come Villy e proprio come lei era stata una madre anaffettiva e rancorosa per
sua figlia; anche il padre dell’autrice, come Edward, era un reduce della Prima
Guerra ed un marito fedifrago che era arrivato al punto di molestare la figlia.
La vita amorosa di Jane Howard fu anch’essa tutt’altro che tranquilla,
costellata di relazioni diverse, molte delle quali problematiche, ma trovo lo
stesso ridicolo che una scrittrice del suo calibro fosse ricordata più per la sua
“turbolenta vita sentimentale” che per la sua imponente opera letteraria.
Il tempo dell’attesa
si conclude con l’attacco di Pearl Harbor. Con la paura che il conflitto non
finisca più, con un membro della famiglia che chissà dov’è, con un amore che
forse sta nascendo, con uno che forse è finito, con più di un dubbio e nessuna
risposta.
Digerirò lentamente anche questo capitolo, poi aspetterò che
mi risalga la febbre Cazalet per
correre di nuovo in libreria in disperata ricerca del terzo volume. So già che
non ci vorrà molto, perché non vedo l’ora di tornare a indagare tra le pieghe
delle loro normalissime vite.